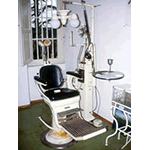(famiglia patriarcale del 1920)
Le famiglie patriarcali di una volta erano litigiose come i Simpson, simpatiche come quella di “Happy Day” o pasticcione come le attuali famiglie allargate?
La famiglia contadina patriarcale si è disgregata con la modernità perché l’invenzione di nuovi mezzi agricoli ha permesso di poter lavorare la terra con meno braccia. Per un piccolo podere di 15 biolche, per esempio lavoravano, un tempo, per quasi 12 ore al giorno, 6-7 adulti. Ora, per la stessa superficie basta e avanza il lavoro di due persone, che possono permettersi anche di svolgere un’altra attività.
Se chiedo alla Signora Armentina della società contadina della sua gioventù, ricorda solo una grande miseria. Riecheggiano ancora alle sue orecchie le esclamazioni della Signora Cesira venuta a chiedere un po’ di farina per i suoi 7 figli: «Oh Lina, incoeu i me’ fieu an gan propria gnent, am dareset un po’d farina per la pulenta?» (O Lina, anche oggi i miei figli non hanno nulla da mangiare. Mi daresti un po' di polenta?) Sì, perché i ricordi arrivano alla sua mente solo in dialetto. Ricordi di povertà, di come mamma Lina aiutava quelli più bisognosi di lei. A casa sua non erano ricchi, ma almeno si mangiava tutti i giorni, anche durante la guerra. Una famiglia di gran lavoratori la sua. Guardando nel passato rammenta che «non c’erano cose né belle, né simpatiche, si doveva lavorare e basta. La terra, come nelle favole, era generosa solo se gli dedicavi tutte le tue energie. C’era sempre qualcosa da fare: falciare l’erba, mietere il grano, battere la canapa, rastrellare il fieno, mungere, fare il pane per l’intera settimana, travasare il vino, insaccare le salcicce, filare la lana. Tutto e di più ». Così sentenzia l’Armentina.
Però, poco a poco, si delinea nella sua mente la personalità di nonno Orazio, il padre-padrone della famiglia, il patriarca la cui autorità non è mai stata messa in dubbio da nessuno dei figli o dai generi perché aveva saputo, con il tempo, far vivere la sua prole in una certa agiatezza. Nonno Orazio, oltre al podere, commerciava in bestiame con la vicina Toscana. Nella tarda primavera s’incamminava a piedi con le bestie e 3 o 4 vaccari, percorrendo, tra andata e ritorno, anche 200 km. Ritornava orgoglioso degli scambi o delle vendite. Infatti di questi viaggi riportava olio e sale, i due generi alimentari che la sua terra non poteva produrre.
Ecco il racconto di Armentina:
«Quando sono nata, negli anni Venti, in casa vivevano 11 persone, di cui tre bambine. Poi due giovani zie si sono sposate e siamo rimasti in 9 di cui 4 maschi adulti e 5 femmine. Successivamente sono nati altri bambini.
L’incontestabile figura di Orazio regnava su tutti noi. La mattina o la sera, intorno al tavolo, discuteva con gli uomini i lavori da fare: erano ordini precisi, netti, indiscutibili. Se c’erano delle controversie era lui a redimerle. Insomma era il grande saggio e, a distanza di tempo, mi è rimasta una percezione molto positiva di quest’uomo, malgrado la sua severità.
La figura della “razdora”, la padrona di casa, veniva assunta